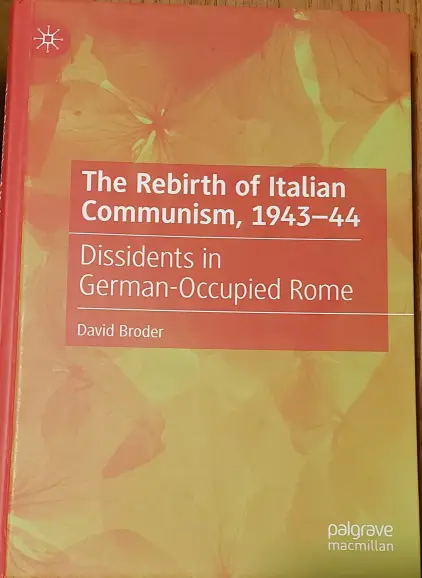Riceviamo e pubblichiamo quesot contributo dai compagni della redazione Il Pungolo Rosso, già disponibile sul loro sito (vedi qui):
L’”altra resistenza”:
una storia scomoda e volutamente occultata
– di Peppe D’Alesio
Gli eventi di questi ultimi mesi, segnati dalla vittoria alle elezioni e dall’approdo al governo di un partito, Fratelli d’Italia, erede del MSI e, seppur in maniera indiretta, dei repubblichini di Salò, ha riportato in auge il tema dell’antifascismo e riacceso i riflettori sui “valori della resistenza” e della lotta di liberazione partigiana durante la seconda guerra mondiale, che sarebbero insidiati e messi in discussione dall’attuale esecutivo. Si tratta di un leit motiv che col passare del tempo è diventato sempre più trito e ritrito: un “antifascismo” da salotto televisivo che, nel celebrare i fasti di una presunta “età dell’oro” della democrazia borghese nostrana con tanto di richiami alla “costituzione più bella del mondo”, è sempre più funzionale alla difesa dello status quo esistente, ovvero del dominio borghese e del suo sistema di sfruttamento che, per dirla con Lenin, di regola assume la sembianza “democratica” quale suo involucro ideale.
La storia, come si sa, la scrivono i vincitori. Mai questa asserzione fu più corrispondente al vero come nel caso della resistenza al nazifascismo: nei quasi 80 anni che ci separano da quegli eventi si sono versati fiumi e fiumi d’inchiostro, plasmando i programmi di storia delle scuole e delle università e l’intero sistema culturale, artistico e cinematografico in funzione del dogma di una storiografia ufficiale tesa a celebrare i fasti del CLN, cioè il blocco politico tra DC, PCI, PSI, liberali ed azionisti, quali unici protagonisti ed “eroi” della liberazione dal nazifascismo. Una rappresentazione agiografica di quel “compromesso storico” ante litteram suggellato dalla “svolta di Salerno” che Stalin e Togliatti imposero a un PCI divenuto realmente un “partito nuovo”, un nuovo partito oramai del tutto svuotato dal profilo rivoluzionario che aveva caratterizzato il PCd’I di Livorno, sacrificandone ogni istanza classista e anticapitalista sull’altare del nuovo corso nazionalpopolare e della “democrazia progressiva”, abili espedienti per mascherare la definitiva accettazione da parte del suo gruppo dirigente dell’ordine economico e politico borghese.
Non deve sorprendere, quindi, che questa storiografia abbia volutamente dimenticato e occultato tutte quelle forze d’attrito prodotte dal movimento di classe, da migliaia di lavoratori ed operai, all’interno della resistenza antifascista: un ampio, articolato ed eterogeneo panorama di forze politiche e movimenti sociali che, malgrado le condizioni oggettivamente proibitive poste dalla seconda guerra mondiale, dalla brutale occupazione hitleriana e dalla altrettanto brutale opera della “repubblica di Salò”, hanno contrastato e messo in discussione l’opportunismo e l’interclassismo del PCI togliattiano.
Il recente lavoro di David Broder The Rebirth of Italian Communism, 1943-44. Dissidents in German-Occupied Rome ha il grande merito di tornare a far luce su una storia censurata per decenni, sulla quale ben poco è stato tramandato alle generazioni che non hanno vissuto l’epoca della seconda guerra mondiale, su tutte l’esperienza del Movimento comunista d’Italia, meglio noto come “Bandiera Rossa Roma” dal nome della testata e della città nella quale questa organizzazione si è sviluppata nel breve volgere del biennio 1943-45. Si tratta di uno dei tanti gruppi del “dissenso comunista” che in quegli anni si erano formati in Italia in contrapposizione al corso opportunista e interclassista del PCI, protagonisti di primo piano della lotta antifascista nella capitale occupata dal terzo Reich e la cui esistenza era stata narrata per la prima volta sul finire degli anni ’70 da Silverio Corvisieri nel testo “Bandiera rossa nella resistenza romana”, dopo oltre 30 anni di totale oblio politico.
Ripercorrendo la breve e tumultuosa storia di Bandiera Rossa, si scoprirà che il dissenso comunista in quegli anni, pur se minoritario, era tutt’altro che marginale: tra il 1943 e il 1944 il MCd’I godeva nei quartieri della capitale di un sostegno militante pari se non addirittura maggiore di quello registrato dal PCI togliattiano, e soprattutto largamente prevalente nelle borgate e tra i settori proletari, raccogliendo consensi sulla base di una chiara e inequivoca contrapposizione alla linea della collaborazione di classe con le forze borghesi (prima il CLN, poi il governo Badoglio) e del richiamo alla rivoluzione russa e all’instaurazione del sistema dei soviet quale bussola principale per l’azione dei comunisti all’interno della resistenza antifascista. Un richiamo che per certi versi assumeva contorni confusi, in cui un generoso afflato anticapitalista e internazionalista si abbinava a una fede talvolta cieca nell’Urss di Stalin (e quindi incapace di comprendere che la politica del PCI era tutt’uno con quella di Mosca), ma i cui limiti di analisi erano per certi versi fisiologici se si tiene conto che il ventennio fascista aveva fortemente limitato e disarticolato la possibilità di conoscere il dibattito e il reale andamento degli eventi successivi alla morte di Lenin all’interno del Movimento comunista internazionale.
In realtà, è proprio a partire da queste esperienze organizzate di dissenso, che inizieranno ad auto-alimentarsi una serie di “miti” che ancora oggi sono duri a morire: su tutti il mito legato al filone della “resistenza tradita” e al suo principale interprete, Pietro Secchia. Quest’ultimo, a cui nel secondo dopoguerra è stata affibbiata l’aura leggendaria del “grande oppositore” di Togliatti e del cosiddetto “nuovo corso” intrapreso con la svolta di Salerno, ne è stato in realtà uno dei principali propugnatori e difensori. Al di là di singoli ed episodici mal di pancia verso le forme più spregiudicate di asservimento alle politiche di collaborazione di classe assunte da Togliatti all’indomani della Costituente e dell’ingresso del PCI al governo, i fatti testimoniano come Secchia abbia sempre non solo accettato le linee-guida alla base di tali scelte, ma ne sia stato uno tra i più zelanti interpreti, soprattutto nei tornanti più complessi della guerra di liberazione.
Il caso più eclatante è il violentissimo corsivo pubblicato da Secchia nel dicembre 1943 sul numero 6 della rivista “La nostra Lotta”, in cui già il titolo (“Il «sinistrismo» maschera della Gestapo”) è indicativo della furia con cui la direzione del PCI mirava a distruggere e delegittimare ogni dissenso alla propria sinistra, marchiando con l’infamia del “filonazismo” migliaia di comunisti che il più delle volte combattevano fianco a fianco con i proletari del PCI nella lotta antifascista. Uno schema tristemente ereditato dai processi di Mosca con i quali, facendo leva sulle più infami calunnie, la direzione stalinista dello stato russo annientò tra il 1936 e il 1938 la quasi totalità della vecchia guardia bolscevica. Uno schema la cui applicazione fu tanto più vile se si tiene conto che nell’Italia occupata dai nazisti ciò equivaleva a condannare centinaia di comunisti al fuoco incrociato del fascismo da una parte e dell’”antifascismo” borghese-reazionario delle potenze alleate e di Badoglio, dall’altra.
Il summenzionato articolo, con il quale Secchia puntava a sopprimere il dissenso comunista e classista nel nord Italia, rappresentato soprattutto dalle formazioni partigiane afferenti all’organizzazione Stella Rossa-Partito comunista integrale presente in Piemonte e Prometeo (Partito Comunista Internazionalista) in Lombardia, ricalcava lo stesso canovaccio di calunnie e di falsità che il PCI avrebbe adottato nei confronti di altre analoghe formazioni nel centro-sud: su tutte proprio Bandiera Rossa Roma, i cui militanti avevano in innumerevoli occasioni dato prova del loro irriducibile odio per il nazifascismo con azioni eroiche e spettacolari a danni degli occupanti tedeschi a cavallo tra il 1943 e il 1944, e che non a caso furono l’organizzazione che pagò il più grande tributo di sangue nella strage nazista delle Fosse Ardeatine (dei 335 partigiani e civili uccisi, oltre 50 erano di Bandiera Rossa).
In realtà, proprio in quei frangenti i vertici del PCI sentivano forte il fiato sul collo delle svariate formazioni comuniste, dei socialisti di sinistra e di area classista e/o libertaria che vedevano crescere in maniera esponenziale la loro influenza tra le fila di un proletariato provato dalla crisi e dalla fame, e soprattutto smarrito politicamente a seguito della palese capitolazione operata da quel partito che fino ad allora essi avevano creduto dedito unicamente all’opera di instaurazione del socialismo, quindi alla trasformazione della lotta di liberazione dal nazifascismo in lotta rivoluzionaria.
Tale processo era altrettanto se non più tangibile nel Sud Italia e in particolare a Napoli, laddove negli stessi mesi il PCI dovette fare i conti con due eventi dalle conseguenze potenzialmente incalcolabili per le sorti del disegno politico togliattiano: da un lato la “scissione di Montesanto”, che portò per circa due mesi alla coesistenza di due distinte federazioni provinciali a seguito della tenace resistenza di numerosi quadri del PCI napoletano ad accettare la politica del “nuovo corso”, la quale in nome della retorica del “partito di massa” consentiva l’iscrizione al partito finanche di elementi che fino a pochi mesi prima erano apertamente compromessi col fascismo; dall’altro l’esperienza breve, ma memorabile della “CGL rossa” guidata da Enrico Russo, la quale, in contrasto con i vertici del PCI, propagandava tra migliaia di operai il rifiuto dell’”unità nazionale” e la necessità di preservare l’indipendenza di classe, e quindi lo strumento dello sciopero generale quale arma da indirizzare contro gli alleati e i padroni di qualsiasi colore e schieramento politico per rispondere alla fame e allo sfruttamento derivati dallo “sforzo bellico”…
D’altronde, la politica di capitolazione del PCI sull’altare del “fronte democratico” e dell’unità nazionale tutto era fuorché una “svolta” improvvisa o repentina: tale traiettoria era stata in realtà ampiamente preparata, costruita e praticata nel decennio precedente a partire dal VII congresso del Comintern con la nascita dei “fronti popolari”, il cui carattere integralmente controrivoluzionario fu certificato dai tragici eventi spagnoli. Solo un’analisi e una ricostruzione lucida dei fatti e dei processi interni al movimento operaio che hanno preceduto e accompagnato il secondo conflitto mondiale può fare giustizia di quei “miti duri a morire”, svelando come l’opportunismo rappresentato dal PD attuale e dalle “sinistre di governo”, lungo dall’essere il prodotto sic et simpliciter della caduta del muro di Berlino e della fine del “socialismo reale”, affondi in realtà le sue radici più profonde proprio nei decenni ’30 e ’40 del secolo scorso, nei quali ha preso avvio quel lungo ciclo controrivoluzionario a cui assistiamo ancora oggi.
A posteriori, è difficile se non impossibile dire se la lotta di liberazione italiana (e internazionale) avrebbe potuto avere un esito diverso da quello celebrato dalla storiografia borghese (nelle sue varianti liberale, socialdemocratica e togliattiana) come il trionfo della democrazia e della Costituzione “nata dalla resistenza”: se, cioè, la nascita tra il 1943 e il 1944 di un vero partito rivoluzionario e di classe come prodotto dall’agglomerazione dei numerosi gruppi del dissenso comunista sarebbe stato effettivamente in grado di contendere al PCI l’influenza di quelle migliaia di proletari spinti con generosità ed eroismo nella lotta antifascista nella speranza (o nell’illusione) che questa fosse solo la premessa della rivoluzione socialista. Certo: le condizioni oggettive dello scontro imperialista, la doppia occupazione militare e la percezione diffusa nell’immaginario collettivo di milioni di proletari italiani del ruolo dell’esercito alleato quale “liberatore” dal giogo nazifascista, unito alla lunga e certosina opera di annientamento politico e fisico compiuta dallo stalinismo nei confronti di ogni opposizione di sinistra e di ogni residua reminiscenza dell’esempio bolscevico, rendevano una tale impresa quasi proibitiva. D’altro canto, la storia ha sempre dimostrato come le rivoluzioni non siano mai avvenute sul velluto, né tantomeno siano il prodotto di schematismi meccanici, come se avessimo a che fare con la semplice risoluzione di un’equazione algebrica di primo grado… Tutt’altro: le rivoluzioni il più delle volte si sviluppano ed esplodono in condizioni sulla carta “proibitive”… Dunque, non è compito nostro riscrivere un’ipotetica storia della resistenza italiana con il gioco dei “se” e dei “ma”, quanto piuttosto contribuire a fare nuova luce sulle pagine memorabili di lotta di classe scritte dai gruppi della dissidenza comunista, da quelle migliaia di operai e proletari che hanno osato sfidare la realpolitik del CLN e le mire imperialiste alleate, a partire dall’esperienza di Bandiera Rossa Roma. Non certo per enfatizzarne i relativi meriti, bensì per far tesoro di quella sconfitta e ricostruire quel filo rosso necessario a fare piazza pulita dell’ipocrita retorica dei “vincitori”. Partendo dalla verità storica, amara quanto si vuole ma tremendamente reale, che nel novero dei vincitori figurano a pari merito tanto gli “antifascisti” borghesi, quanto i fascisti, prima amnistiati, poi riciclati nelle istituzioni democratiche e infine sdoganati proprio da chi si era spacciato come un loro acerrimo oppositore. E nel novero degli sconfitti figurano quei proletari e quei comunisti che all’indomani della caduta del fascismo hanno dovuto fare i conti con una dittatura del capitale e del profitto differente nelle forme di dominio, ma sostanzialmente analoga nei contenuti.
Narrare e celebrare le gesta dell’”altra resistenza”, serve non solo a restituire ciò che è loro a migliaia di comunisti sepolti da decenni di omertà, mistificazioni e calunnie perpetrate dal PCI e dai suoi epigoni; serve soprattutto da monito per schiere di militanti e di proletari chiamati oggi a ricostruire una prospettiva anticapitalista rivoluzionaria in un frangente storico che vede gli eredi del ventennio ri-occupare, questa volta “democraticamente”, i vertici dello stato borghese. Serve come promemoria per gli eventi futuri, quando nel campo dell’imperialismo occidentale colpito da una profondissima perdita di egemonia nel mondo nel mezzo di una crisi storica del capitalismo, sorgeranno necessariamente fenomeni di feroce mobilitazione reazionaria – di cui la vicenda-Trump è stata solo un blando antipasto – e davanti ad essi scatterà, una volta ancora, l’appello interclassista all’“unità contro la reazione e il fascismo”, a dare il sangue dei proletari per la vittoria della fazione borghese che si ammanterà di progressismo e difesa dei diritti, salvo essere solo l’altra faccia, all’occorrenza altrettanto feroce, della dittatura capitalistica.
Per noi militanti internazionalisti ritornare sulle vicende dell’“altra resistenza” non ha nulla di meramente storiografico; è un invito alla lotta per la rinascita di un movimento proletario del tutto autonomo da ogni frazione e opzione borghese, interna e internazionale (vedi la recente postura “anti-nazista” di Putin), e che proprio in virtù di questa totale autonomia, sarà capace di prospettare all’intera comunità umana la via della liberazione dal capitalismo qualunque forma politica esso si dia.
I comunisti “dissidenti”
della Capitale ( 1943 / 1944 )
– di Pietro Basso
Riprendiamo da Carmilla on line (che l’ha pubblicata l’8 e 9 novembre) la recensione al libro di David Broder, The Rebirth of Italian Communism, 1943-44. Dissidents in German-Occupied Rome, Palgrave Macmillan, 2021.
Come è noto, la letteratura sulla Resistenza italiana al nazi-fascismo negli anni 1943-1945 è pressoché sterminata. Di certo molto più ampia della letteratura sulla coeva rinascita del movimento operaio organizzato. Sono rare, invece, le opere che indagano in profondità il nesso tra questi due processi. E addirittura rarissime sono quelle che svolgono questo tipo di indagine occupandosi dei comunisti dissidenti rispetto alla politica del “partito nuovo” di Togliatti. Lo scritto di David Broder appartiene a questo piccolo campo di studi. E si segnala per la sua particolare lucidità di giudizio, e per il modo con cui tiene assieme la dimensione sociale e quella politica del fenomeno studiato – i “comunisti dissidenti” di Roma organizzati nel Movimento comunista d’Italia o Bandiera rossa -, il “locale”, il nazionale e il contesto internazionale.
Il triennio 1943-1945 è stato un momento particolarmente tumultuoso per l’intera società italiana. Crolla il fascismo. La classe capitalistica e la monarchia manovrano con grande abilità per non restare sepolte sotto le macerie del regime mussoliniano, che hanno per un ventennio supportato. L’Italia è spaccata in due. L’esercito italiano si va disfacendo dentro una “nazione allo sbando”. Tutto il territorio è occupato da eserciti stranieri: l’esercito tedesco in ritirata verso nord al di là della linea gotica, gli eserciti alleati in avanzata dal Sud. Sul piano politico-amministrativo, al centro-nord c’è la repubblica “sociale” di Salò sotto tutela dell’occupante nazista, che mescola una brutale ferocia con la demagogia “anti-capitalista” del fascismo delle origini. Nel Sud la monarchia dei Savoia ormai al tramonto cerca disperatamente di realizzare il passaggio più possibile indolore al campo anti-nazista, tenendo sotto stretto controllo il risveglio della vita sociale e politica a lungo compresse dal fascismo e disinnescando, anche con gli eccidi, il “pericolo comunista”. In due anni e mezzo si avvicendano ben sei governi. Le diverse componenti politiche del movimento proletario, che erano state decimate e disorganizzate dagli apparati repressivi del regime, riavviano la loro attività nel quadro di una intensificazione degli scontri bellici tra i fronti contrapposti, che getta le premesse di una (limitata) guerra civile. Il tutto mentre a livello internazionale si infittiscono a ritmo incalzante le trame e le conferenze tra le potenze che stanno per uscire vincitrici dalla guerra, volte a disegnare il nuovo ordine mondiale, con effetti a cascata sui singoli paesi, Italia inclusa.
La vicenda “locale” che Broder ci presenta è stata dominata in lungo e in largo da questi processi. A chi la guardasse oggi con un arrogante senno di poi, potrebbe apparire semplicemente come il vano annaspare di un pugno di militanti comunisti vittime delle proprie ingenue illusioni rivoluzionarie. Vissuta in presa diretta, invece, è la storia appassionante e drammatica, non limitata ai suoi fisici protagonisti, del tentativo di piccoli settori del movimento proletario italiano e internazionale di fare i conti oltre che con il fascismo, anche con il capitalismo. E di farli sfidando la repressione e il piombo dei nazisti, prima, soffrendo il controllo occhiuto delle polizie democratiche e gli attacchi politici senza tregua del PCI di Togliatti, poi. Il luogo in cui la vicenda si svolge è Roma, l’unica grande città italiana in cui le forze comuniste “dissidenti” hanno avuto una consistenza fino ad un certo momento paragonabile a quelle del PCI in via di rapida ricostituzione su basi completamente diverse dalle originarie del 1921. Forze comuniste “dissidenti” che, con la loro piccola Armata rossa, hanno dato un contributo perfino superiore a quello del PCI nella cacciata dalla capitale delle truppe nazifasciste nel periodo settembre 1943-giugno 1944.
Si deve a Silverio Corvisieri il lavoro più noto, in lingua italiana, sul ruolo svolto dal Movimento comunista d’Italia, o movimento di Bandiera rossa, nella resistenza romana – a cui contribuì con 2.548 militanti (il PCI con 2.336). Si tratta di un testo del 1968 che però, come osserva Broder, è più interessato all’attività militare di questi compagni che alla loro battaglia politica, alla loro resistenza alla politica di unità nazionale e alla loro critica della “degenerazione riformista” del PCI. Il tempo – sul metro del lungo periodo – consente oggi, anzi obbliga, a riconoscere loro di avere se non altro intuito il corso degli avvenimenti susseguenti alla fine della guerra in maniera incomparabilmente più corretta di coloro che li sconfissero e li denigrarono come affetti da infantilismo – questo, almeno per ciò che concerne il ruolo non proprio liberatorio degli Alleati anglo-americani, e gli effetti deleteri che la politica di unità nazionale con la borghesia avrebbe avuto sul proletariato.
Procediamo con ordine. Con una ben congegnata azione repressiva attuata in due momenti (gennaio 1923, autunno 1926), Mussolini e il suo partito-stato riuscirono a smantellare la direzione e i gangli fondamentali della macchina organizzativa del Pcd’I. E costrinsero all’espatrio centinaia di migliaia di proletari simpatizzanti per esso, o sua potenziale area di influenza. Alla messa fuori uso di questa macchina ancora in formazione, concorse pure la scatenata caccia ai trotskisti che si abbatté su Amadeo Bordiga e i suoi più stretti compagni di partito. Sicché al 1943, quando il fascismo inizia a vacillare sotto il peso delle sconfitte militari dell’Asse e degli scioperi operai nelle fabbriche del nord, ciò che rimane in piedi di realmente organizzato del movimento comunista degli anni ‘20 è poco, molto poco. Non esiste alcuna rete di collegamento interna alla penisola. Il centro direttivo del partito legato a Mosca è all’estero (a Parigi). La diaspora è ancor più slabbrata nel campo, assai ristretto, di quanti sono rimasti fedeli alla linea di Bordiga, anche per la sua categorica decisione di sospendere ogni forma di attività politica. Restano in piedi solo esili reti locali. La maledizione del localismo che per secoli ha afflitto e indebolito la borghesia italiana, pesa in questo frangente anche contro la riorganizzazione della classe operaia. Pur avendo alcuni tratti in comune, le dissidenze comuniste di Roma, Napoli, Torino e dell’alto milanese non riescono a coordinarsi tra loro. Anzi, a stento sono consapevoli delle rispettive esistenze e posizioni. Sicché la vicenda del Mcd’I – un nome che, al pari di Pcd’I (Partito comunista d’Italia, non Partito comunista italiano), rimanda a una concezione dell’internazionalismo proletario differente dall’inter-nazionalismo di matrice stalinista e togliattiana – resta una storia peculiare, separata, a sé stante. E questo faciliterà l’azione di quanti hanno operato per distruggerla fisicamente e politicamente, e cancellarne perfino il ricordo.
Con un’attenzione rigorosa e al tempo stesso empatica, David Broder ne ricostruisce la nascita negli “anni della cospirazione” (1939-1942), e ne descrive le radici sociali in un milieu che, data la struttura sociale della Roma fascista e imperiale, è più proletario e popolare che in senso stretto operaio. Gli insediamenti più significativi di Bandiera rossa sono nei quartieri popolari dell’Urbe e nelle borgate: San Lorenzo, Trionfale, Certosa, via Appia, via Tuscolana, via Casilina, Quadraro, Quarticciolo, Certosa. L’attività di questi compagni decisi a restare fedeli all’“autentica tradizione comunista” mette capo nel giugno del 1942 alla pubblicazione del giornale clandestino Scintilla. Tanto nei suoi pregi quanto nei suoi limiti, siamo dentro quel sottosuolo proletario comunista, quella “subcultura antagonistica” rimasta viva in militanti operai e proletari di lungo corso, messi in evidenza da Luigi Cortesi. Si tratta di marxisti autodidatti, carpentieri, elettricisti, ciabattini, grafici, espulsi dalle storie ufficiali del movimento comunista italiano del tempo insieme con i penetranti spunti politici contenuti nei loro abbozzi di analisi della guerra e del dopoguerra. Piccoli cammei disseminati qua e là nei testi a stampa che ci sono arrivati (meno sappiamo delle loro discussioni), che provo qui a mettere in sequenza.
Notevoli sono anzitutto il loro richiamo alla storia internazionale del proletariato rivoluzionario di cui si sentono parte, che fanno cominciare a Lione nel1831. Rivendicano in modo talvolta implicito, talaltra esplicito, mai esauriente, di essere in continuità con la prima fase della vita del Pcd’I, con le battaglie del biennio rosso, e con l’esperienza degli Arditi del popolo. Sorvolando sulle controversie interne al Pcd’I dei primordi, tale rivendicazione esprime l’aspettativa di poter portare a termine il lavoro lasciato incompiuto in quegli anni, arrivando a “fondare una repubblica sovietica sul suolo italiano”. Il più rilevante tratto distintivo di quest’area di compagni è il rifiuto della politica di unità nazionale prima e dopo la svolta di Salerno dell’aprile 1944. Anzi: il rifiuto di ogni forma di collaborazione con la borghesia italiana, di ogni confusione tra antifascismo e anticapitalismo, e tanto più della loro identificazione. Nessuna riabilitazione della classe dominante che ha portato l’Italia al fascismo, alla guerra, alla rovina! Bisogna stare fuori dal CLN, gli operai e i contadini non possono, non debbono gettare il loro sangue per le classi privilegiate. All’unità con la classe dei borghesi i “dissidenti” contrappongono la prospettiva politica dell’unità del fronte di classe. Al diavolo la bandiera tricolore, bandiera rossa! Colpisce anche l’inquadramento della seconda guerra mondiale come “scontro tra poteri imperialisti”, nazifascismo contro blocco a guida statunitense, espressa nel n. 2 di Scintilla. In tale scontro l’Urss è stata trascinata solo dall’aggressione esterna – e la forte diffidenza nei confronti dei “liberatori” anglo-americani, di cui non si dimentica la funzione di primo piano avuta nei tentativi di soffocare la rivoluzione russa nella culla. Questi militanti si rifiutano di vedere nei tedeschi in quanto tali il nemico, e valorizzano il sentimento anti-fascista e anti-nazista espresso dai migliori elementi dell’esercito tedesco, indirizzando ai soldati tedeschi dal retroterra operaio l’invito a rivoltarsi contro i propri generali. Se poniamo questa attitudine e questo invito di impronta internazionalista a confronto con la direttiva nazionalista del PCI di colpire i tedeschi quali che fossero, in quanto tedeschi occupanti; se li mettiamo a confronto con la logica altrettanto nazionalista che ispirò l’attentato di via Rasella; ci troviamo di fronte a due differenti modi di intendere la lotta al nazi-fascismo tra loro alternativi, corrispondenti, ove si vada ad indagare fino in fondo, a due differenti classi, perfino a due differenti prospettive storiche. Quella dei militanti del Mcd’I appare, quanto meno nei testi più maturi, rivolta alla “seconda guerra” da combattere una volta vinta quella al nazifascismo: la guerra contro il mondo capitalistico. Si tratta, affermano, di “trasformare la guerra contro il nazismo nella guerra contro tutto il capitalismo”. Rivendicano con orgoglio: “noi non siamo anti-fascisti, siamo comunisti”. Spriano nota che il loro simpatizzante Riccardo Tenerini, un giovane perugino, arriva a preconizzare per il dopo-guerra lo scontro tra il capitalismo anglo-sassone (i “poteri imperialisti”) e il proletariato mondiale nei seguenti termini:
“Viene ora la seconda guerra: quella rivoluzionaria, quella che il proletariato deve combattere e vincere contro il mondo capitalista… La rivoluzione anticapitalista è in marcia, non si arresterà che ad eliminazione totale di ogni residuo del mondo attuale… L’ora della rivoluzione liberatrice è vicina… W Stalin, W l’Unione sovietica, patria di tutti i lavoratori. Evviva il Partito comunista d’Italia, evviva l’Internazionale comunista.”
In maniera più sfumata e confusa la tematica della “doppia rivoluzione” è presente anche nei testi dei dissidenti romani. Ad esempio nel documento di fine 1944 intitolato “La via maestra”, il Mcd’I espone questa prospettiva, sebbene in una forma decisamente volontaristica:
“[il nostro] movimento si distingue per la sua netta intransigenza, che non ammette ritardi né compromessi perché sostiene che l’ora della abolizione del capitalismo è suonata, e che il proletariato, per impedire la minaccia di nuove oppressioni e di nuove barbarie, deve conquistare il potere proprio in questo momento, in nome dei principi universali del comunismo.”
Questi spunti eterodossi di matrice classista rivoluzionaria cozzano e si infrangono contro quella che David Broder chiama “idolatria” di Stalin e dell’Urss staliniana. Per i militanti di Bandiera rossa, infatti, la continuità tra la Russia di Lenin e quella di Stalin è un dogma. Anche se il loro stalinismo ha certi tratti sui generis (“an idiosyncratic Stalinism of their own”). Rifiutano di norma l’atteggiamento passivo insito nell’attesa “addavenì Baffone”, considerando la liberazione dal giogo capitalistico un compito del proletariato italiano. Reinterpretano a modo loro una serie di atti dell’Urss di Stalin, a cominciare dal patto Molotov-von Ribbentrop, giustificato dalla “ragion di stato”, e lo considerano non vincolante per l’Internazionale. I comunisti italiani, si sostiene, non sono “agenti di Mosca”. Collaborano con Mosca come con tutti i movimenti proletari del mondo, e perciò non sono affatto obbligati a “rivalutare” nazismo e fascismo, come invece per un tratto avvenne. Lo stesso scioglimento dell’Internazionale è presentato come il riconoscimento da parte di Stalin del grado di maturità raggiunto dai singoli partiti comunisti – un’interpretazione del tutto infondata, essendo chiarissimo, invece, che lo scioglimento dell’Internazionale è stato un passaggio ineludibile nel processo di appeasement tra l’Urss e gli Stati Uniti. Qui le spire dell’idolatria di Stalin e dell’Urss si mostrano in tutto il loro potere soffocante.
Per quanto incompleti e contraddittori siano, e lo sono, il valore degli spunti, delle intuizioni, delle anticipazioni del corso futuro degli avvenimenti, risalta meglio oggi a ottant’anni di distanza se li si pone a confronto con la funzione anti-proletaria e contro-rivoluzionaria svolta dagli imperialisti anglo-americani sia in Italia che ai quattro angoli del globo terrestre; con il carattere sempre meno “progressivo” acquisito dalla “repubblica nata dalla Resistenza” non appena si è ridotto il grado di attività e combattività della classe lavoratrice; con la decomposizione e la totale scomparsa del PCI togliattiano avvenute lungo la linea continua di deriva socialdemocratica temuta e denunciata in tempo reale da militanti del Mcd’I come Mucci, Poce, Cretara, Sabatini, De Luca (in questi giorni alcuni degli ultimi epigoni del PCI sono addirittura dediti all’abbraccio con forze di orientamento razzista e semi-fascista…). Riletti oggi, gli anatemi scagliati dagli Amendola, dai Secchia e dai loro accoliti contro questi “estremisti infantili”, “settari”, esponenti di una “vecchia opposizione pro-trotskista e bordighista”, agenti provocatori, e perfino “maschera della Gestapo” (!!!!), appaiono in tutta la loro miseria politica e morale. Anatemi da guardiani non tanto né solo dell’ortodossia stalinista, quanto della stabilizzazione borghese dell’Italia post-fascista sulla pelle del proletariato – la sola classe sociale che si batté contro il fascismo ascendente nei primi anni ‘20 e fu, con i suoi scioperi, il principale fattore interno della caduta del fascismo. La loro violenza verbale nei confronti di questi compagni, e di tutto ciò che in loro poteva suonare proveniente dalla tradizione della Sinistra comunista e dal leninismo di Lenin, si disvela nel suo carattere di disciplinamento forzato al nuovo ordine democratico nel quale al posto di comando c’è la stessa vecchia, impunita borghesia che aveva portato al potere il partito fascista.
Per quanto possano esserci stati attriti tattici di secondaria importanza, la svolta a cui si opposero come poterono nuclei organizzati di comunisti come quello di Roma, veniva dalla direzione stalinista del movimento comunista internazionale. Questo dato essenziale, oggi convalidato da qualsiasi ricerca storica degna del nome, i “comunisti dissidenti” di Bandiera rossa non riuscirono né a capirlo né a crederlo, restando così prigionieri delle proprie illusioni e votati alla sconfitta. La loro convinzione che fossero mature le condizioni per un nuovo assalto al cielo era infondata per il loro errato giudizio sullo stalinismo e sull’Urss. E lo era anche, a un livello ancora più profondo, per ciò che riguarda i rapporti di forza su scala internazionale tra classe capitalistica e movimento proletario. Vediamo il primo aspetto, torneremo in seguito sul secondo.
Il 26 novembre 1943, nel suo discorso da Mosca “L’Italia in guerra contro la Germania hitleriana”, Togliatti afferma in modo inequivocabile sull’Italia post-fascista quanto segue:
“Sarebbe assurdo pensare al governo di un solo partito o al dominio di una sola classe. L’unità e la collaborazione di tutte le forze democratiche e popolari dovranno essere l’asse della politica italiana, la base su cui verrà costruito un vero regime democratico, che distrugga le radici del fascismo e dia alla nazione delle garanzie serie contro ogni possibile ripetizione della tragica avventura ch’è costata all’Italia il suo benessere, la sua libertà, la sua indipendenza, il suo onore. Ma questo non vuol dire che nella vita del paese non debbano essere operate profonde riforme… la nuova democrazia italiana… con un ragionevole intervento dello stato dovrà impedire che dei gruppi di plutocrati avidi ed egoisti [gli Agnelli ad esempio? – n.] sfruttino il monopolio delle risorse del paese per asservire il popolo intero e gettare il paese nell’abisso di criminali avventure di guerra.”
Questa linea di condotta era perfettamente coerente con l’obiettivo strategico perseguito da Stalin, che non era più la rivoluzione proletaria internazionale, cui lo stalinismo aveva rinunciato da tempo, bensì la costruzione in Russia di un industrialismo di stato capace di ridurre il gap economico-tecnologico rispetto alle grandi potenze occidentali. In tale prospettiva strategica di coesistenza e di concorrenza pacifica tra il campo occidentale e quello del “socialismo reale”, rientrava la pace con gli imperialisti d’Occidente, la divisione del mondo in sfere di influenza, nonché la spartizione dell’Europa che prevedeva l’assegnazione dell’Italia al dominio delle democrazie anglo-sassoni. Contro questo muro si infranse l’attività politica del Mcd’I che pagò dazio alla fine della guerra con la sua rapida disgregazione e scomparsa. Una fine amara perché la battaglia politica del Mcd’I per la rinascita di un movimento comunista rivoluzionario in Italia non si era certo limitata ai giornali e alla propaganda delle proprie idee, ma aveva visto la sua partecipazione alla resistenza armata anti-nazista e anti-fascista, svolta da posizioni autonome. Broder ricostruisce con estrema puntualità il peculiare modo di partecipare alla resistenza di questo insieme di militanti. Parlo di insieme perché il Mcd’I non fu mai un organismo centralizzato, a differenza del PCI-partito nuovo, restando piuttosto, dall’inizio alla fine, una federazione di vari gruppi di comunisti attraversati da influenze ideologiche molteplici (incluso l’anarchismo). Nella biblioteca di sezione del Mcd’I la “Storia della rivoluzione russa” di Trotsky, e scritti di Bordiga, Bucharin o Malatesta potevano stare accanto alle opere di Marx Engels e Lenin senza provocare guerre di religione. L’aspirazione di questi compagni ad essere dei militanti ben attrezzati si materializza nella scuola di formazione di Grotta Rossa. Già negli “anni della cospirazione” la loro priorità non era l’azione militare, bensì la ricostituzione dell’organizzazione comunista. Questa impostazione consentirà a Bandiera rossa di essere uno dei pochissimi esempi di “leadership politica comunista” nell’azione militare nel corso di tutta la resistenza italiana. Quando su Roma, dal settembre 1943, si stringe la morsa sanguinaria delle truppe naziste ed inizia l’attività militare dell’Armata rossa (così il Mcd’I denominò i suoi nuclei d’azione armata), la priorità di questa area di compagni rimane non lo scontro frontale con i nazisti, ma la preparazione delle forze e delle strutture per quando le truppe naziste avrebbero lasciato la città. Il loro sforzo principale – riuscito solo in piccola parte – resta il radicamento sociale negli strati proletari e popolari più schiacciati, ridotti alla fame nera. Tuttavia la Wehrmacht e la polizia fascista, mettendo in atto la coscrizione obbligatoria e la deportazione, obbligano chi intenda resistere a questa duplice violenza ad organizzarsi in gruppi armati. Il Mcd’I non si tira indietro. La consistenza delle sue milizie sarà sempre piuttosto limitata, ma il movimento arriva ad avere 27 unità locali, 8 gruppi speciali, e collegamenti con 39 bande “esterne”, alcune delle quali estranee ai suoi orientamenti politici. Pagherà un pesante tributo di sangue nei 9 mesi di occupazione nazista della città, designata capitale della Repubblica sociale italiana.
Seguendo un tracciato del tutto differente, i Gap del PCI operanti per lo più nel centro di Roma, furono dediti esclusivamente ad un’attività militare finalizzata a provocare rappresaglie naziste come strumento per stimolare la popolazione a sollevarsi contro lo straniero nell’ottica di un “nuovo risorgimento” dell’Italia – nelle parole di Rosario Bentivegna, uno dei gappisti più noti, a “scuotere la popolazione, eccitarla in modo che si sollevasse contro i tedeschi”, una tattica fallimentare perché a Roma non ci fu alcuna insurrezione. Ci fu, invece, una catena di sanguinose repressioni nazi-fasciste: tra le più brutali quelle compiute al Trionfale, al Quadraro e l’eccidio delle Fosse ardeatine dopo l’attentato di via Rasella, organizzato dai GAP il 23 marzo 1944 contro una compagnia di riservisti alto-atesini senza ruoli di combattimento. In tutti e tre i casi gli appartenenti al Mcd’I e all’Armata rossa pagarono il prezzo più alto tra le diverse componenti della resistenza romana: 68 dei 335 prigionieri (e passanti) fucilati alle Fosse ardeatine erano militanti del Mcd’I che – con ottime ragioni, a mio avviso – criticò i metodi terroristici dei Gap e si espresse a favore di un approccio “difensivo” alla lotta contro le forze nazifasciste in ritirata.
Nonostante queste difficilissime prove, il prestigio e il seguito del Mcd’I continuano a crescere fino alla fine del 1944, quando i membri del movimento oltrepassano le 13.000 unità (ma il PCI, con una progressione fulminea, aveva già oltrepassato i 50.000). Il momento di massima euforia è nei giorni successivi all’entrata delle truppe alleate in Roma avvenuta il 4 giugno 1944. Scrive Corvisieri:
“I nove terribili mesi dell’occupazione e del terrore nazifascista erano finiti. Per i militanti più vecchi come De Luca (uscito da Regina Coeli alla testa di un corteo di detenuti politici), Poce, Volpini e tanti altri l’attesa era stata molto più lunga: da venti anni aspettavano quelle radiose giornate. La fame e la miseria generale, che tuttavia restavano, non frenarono le manifestazioni popolari di entusiasmo per la ritrovata libertà. La fine di un incubo. I militanti più attivi del Mcd’I si erano impossessati delle sedi necessarie alla loro attività e s’impegnarono a fondo nel reclutare giovani per l’Armata Rossa. Poce, a conferma dell’autorità di cui godeva, fu affiancato al vice-questore.
Furono giorni di vertigine per chi aveva tanto sofferto e anelato alla sconfitta del fascismo come nella necessaria premessa per la rivoluzione socialista. Il sogno di allestire un esercito popolare di liberazione, una Armata Rossa, apparve per qualche tempo di possibile realizzazione. Durante la occupazione di Roma, Armata Rossa era stata una piccola ma agguerrita formazione che raggruppava alcune centinaia di combattenti del Mcd’I e del PCI (sbandati o dissidenti dal partito); ora si trattava di sviluppare questo nucleo fino ad avere una forza armata popolare che conducesse autonomamente la guerra contro i tedeschi e i fascisti, affiancandosi agli Alleati e stabilendo un contatto non solo ideale con i partigiani del nord.”
In pochi giorni la campagna di reclutamento dei volontari vede l’adesione di 40-50 mila giovani. E immediatamente scatta l’altolà degli Alleati “liberatori”, che “preoccupati dal movimento dei volontari che sarebbe stato difficile da controllare, emisero un decreto che ordinava la sospensione degli arruolamenti e ogni altra iniziativa non autorizzata. Poce, avendo insistito il Mcd’I nella sua azione, passò da vice-questore al carcere. Tornò in quella Regina Coeli che aveva conosciuto a più riprese durante il fascismo e ci restò per un paio di mesi.”
Fatto altamente simbolico dell’avvio della democrazia post-fascista (non però anti-fascista, come usa dire). L’esperienza romana è uno dei pochi casi in cui, pur essendoci rapporti con i comandi anglo-americani, viene mantenuta sia l’autonomia dell’organizzazione comunista che quella dei gruppi armati, perché “i proletari combattono per sé stessi”, e non per la borghesia. Poce si scontra con questi comandi quando pretendono di imporre al Mcd’I che a Roma non ci debba essere una insurrezione, e rinuncia al suo proposito solo quando sa che PCI, Psi e azionisti hanno accettato il diktat. Alla vigilia dell’occupazione di Roma da parte delle truppe alleate si rifiuta di mettere le proprie milizie sotto il controllo dei commissariati romani di pubblica sicurezza. Sennonché è proprio questa autonomia che i nuovi padroni, alleati e protettori dei vecchi padroni, non intendono in alcun modo accettare, tant’è che oltre Poce, anche altri militanti del Mcd’I vengono arrestati dalle forze della repressione democratica. Del resto, il 19 luglio 1943 i bombardamenti alleati su Roma erano cominciati, guarda caso, dal quartiere rosso di San Lorenzo con una strage di 1.600 persone. Nello scontro inter-imperialistico tra truppe nazifasciste e truppe a guida anglo-americana appariva sempre più chiaro, ormai, che la Resistenza avrebbe dovuto avere più un ruolo subalterno. Come ebbe poi a riconoscere senza mezzi termini Ferruccio Parri: “Rifiutiamo per noi le penne del pavone. Sono gli Alleati che hanno sconfitto il nazismo e la sua triste appendice“.
Un giudizio storico-politico che, contro ogni bolsa retorica resistenziale di “estrema sinistra”, oggi appare indiscutibile. Per dirla con Paul Ginsborg: “la Resistenza non fu mai servile nei confronti degli Alleati, ma non può esservi alcun dubbio sulla sua essenziale subordinazione” ai comandi Alleati. I “comunisti dissidenti” di Roma cercarono invano di sottrarsi a questo amaro destino di donatori di sangue per la vittoria degli Alleati (imperialisti). Decimati dai nazi-fascisti; controllati, intimiditi e colpiti dalle autorità alleate; calunniati, minacciati, attaccati politicamente dal PCI; grazie alla loro speciale dedizione alla causa, erano riusciti a crescere fino alla fine del 1944, ma non ebbero la forza di tenere il campo dopo il crollo del nazifascismo e la fine della guerra. Si divisero prima tra favorevoli e contrari all’ingresso nel PCI; si dispersero poi in più direzioni, per dissolversi completamente nell’estate del 1947. Il PCI accettò nelle sue fila la gran parte dei militanti di base, respingendo invece i capi.
La vittoria del PCI sul Mcd’I è, in realtà, parte di un processo assai più ampio e profondo di nuova stabilizzazione del capitalismo globale dopo il trentennio di devastanti sconvolgimenti che va dal 1914 al 1945 passando per due guerre mondiali e la Grande Depressione. L’impressionante salasso di capitale fisso e di esseri umani avvenuto in questo frangente; il totale tracollo delle tre potenze dell’Asse; l’emergere sulle loro rovine e sul disfacimento dell’impero coloniale britannico di un nuovo, potentissimo guardiano dell’ordine capitalistico mondiale dotato di armi di sterminio di massa e in possesso di ingenti quantità di capitali da anticipare ai paesi europei vinti, gli Stati Uniti d’America; aprono una fase di forte ripresa dell’economia. E per i paesi europei, un periodo di pace nel quale i proletari in massa vengono risucchiati in una macchina produttiva democratica (fuori dai luoghi di lavoro) che pare promettergli un futuro differente dall’incubo vissuto da due generazioni di lavoratori. Non erano stati solo i dissidenti romani, erano stati in centinaia di migliaia, se non milioni di proletari italiani, jugoslavi, greci, albanesi e così via a sognare la ripresa e la conclusione vittoriosa del ciclo rivoluzionario degli anni 1917-1927. Che non si trattasse di sparuti gruppi settari e infantili, lo hanno riconosciuto in seguito gli stessi massimi pedagoghi della “via italiana al socialismo”. Ha scritto ad esempio Giorgio Amendola: “Vi era nel partito un profondo contrasto tra una grande parte degli aderenti che vedeva l’insurrezione [del 25 aprile ‘45] in maniera ingenua come già l’inizio del socialismo, e il gruppo dirigente che aveva coscienza dei limiti di classe della situazione italiana e cercava di correggere questo orientamento massimalista”. E lo stesso Togliatti, ha confessato ripetutamente che fu dura far comprendere alla massa dei militanti che la scelta di Salerno e dell’unità nazionale con la borghesia italiana in quanto tale non era una furba tattica doppiogiochista per fregare gli avversari borghesi, bensì la definitiva rinuncia alla prospettiva della rivoluzione sociale.
Con la mano ferma dello studioso che sa bene quello che dice, con ammirevole sobrietà nello stile, David Broder ci conduce a vedere e a vivere il progressivo impatto devastante che questo nuovo corso del capitalismo mondiale e del “movimento comunista internazionale” ebbe sui “dissidenti comunisti” di Roma. Davvero un libro da leggere. Che si chiude con queste parole:
“i militanti del Mcd’I erano guidati più dalla fede in ciò per cui stavano combattendo che da una chiara idea su come raggiungere il proprio scopo. Questi proletari romani sognavano il sol dell’avvenire e una vittoria che non era soltanto degna della lotta per conseguirla, ma anche inevitabile, assicurata dal movimento della storia. Questa fede permise una coesione che altrimenti sarebbe mancata alla loro organizzazione piuttosto traballante, una teleologia capace di dare senso ai loro terribili sacrifici. Ma quando l’obiettivo finale scomparve dal loro orizzonte, non gli rimase alcuna tradizione da difendere. Alcuni di loro modificarono il proprio modo di vedere per abbracciare lo spirito dei tempi; i più rivolsero semplicemente le loro speranze al di fuori della politica. Non ci fu alcun lieto fine, né alcuna redenzione, e neppure un articolo di giornale che spiegasse perché gli ultimi seguaci avevano staccato la spina. Non potettero avanzare alcuna giustificazione, né indicare una svolta sbagliata. La loro storia non è stata altro che una storia di fede nel futuro, e della sua sconfitta.”
Eppure: se un domani ci sarà una Roma senza Quirinale, senza Vaticano, senza i pescecani e senza la sterminata burocrazia che oggi l’appestano. Se sui sette colli nuove generazioni di proletari dovessero fondare la Comune romana sognata nel 1943-’45 da questi sconfitti esploratori del futuro. Allora la loro vicenda, i loro nomi sconosciuti grandeggeranno sulle forze nazionali e internazionali e sui “celebri personaggi” che li dispersero.